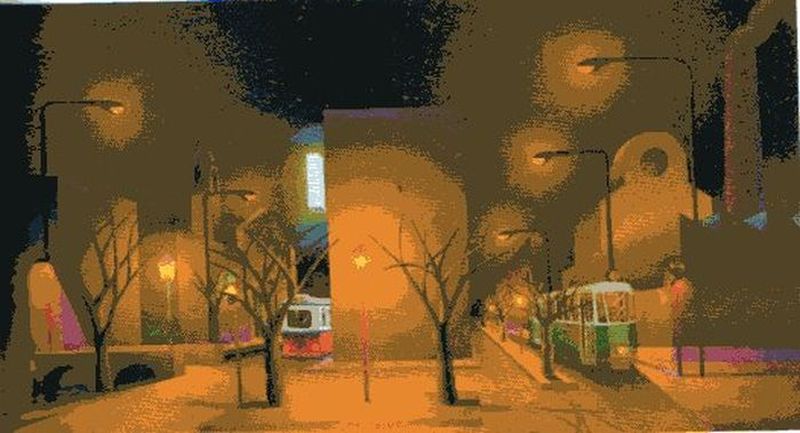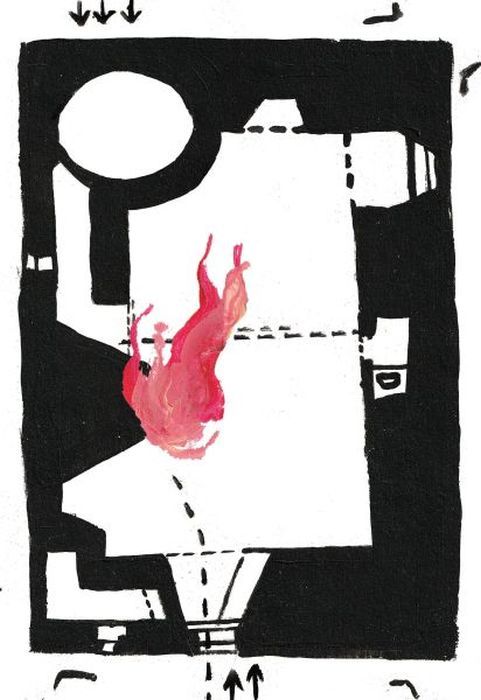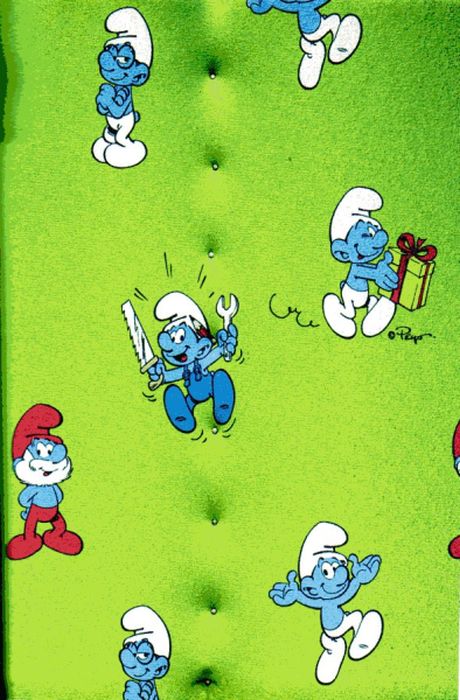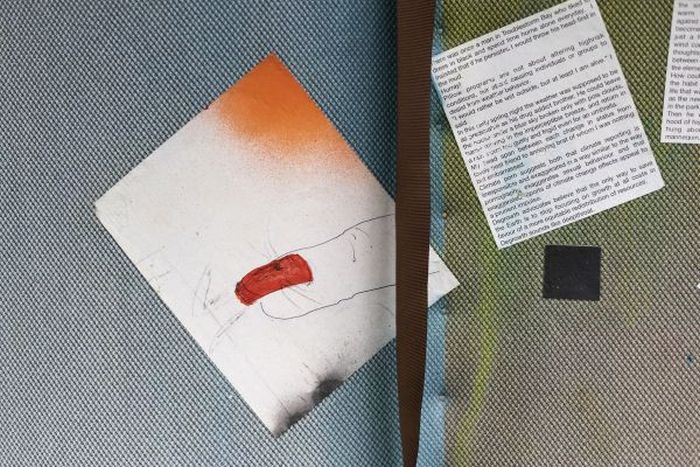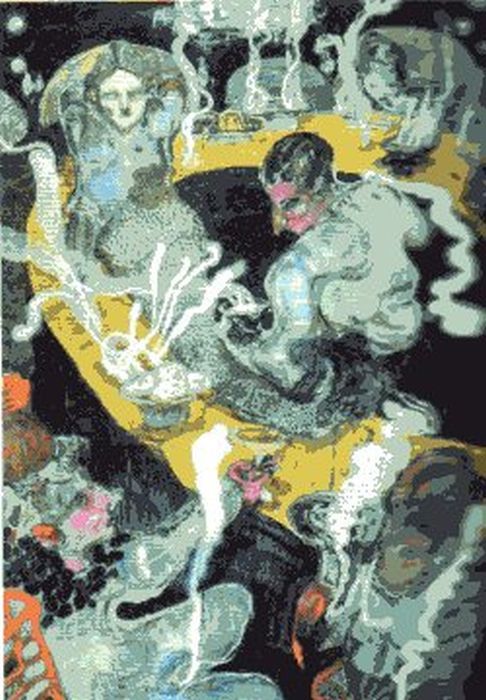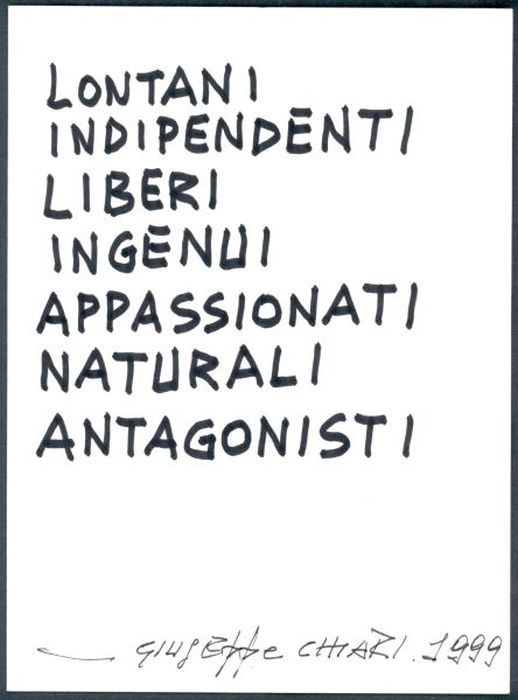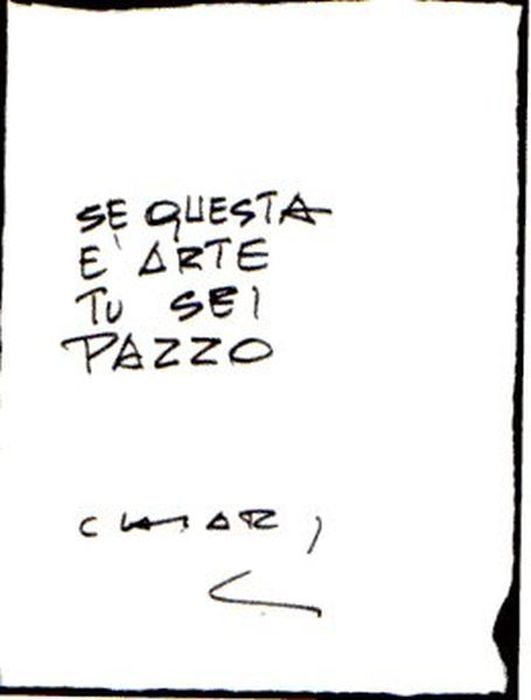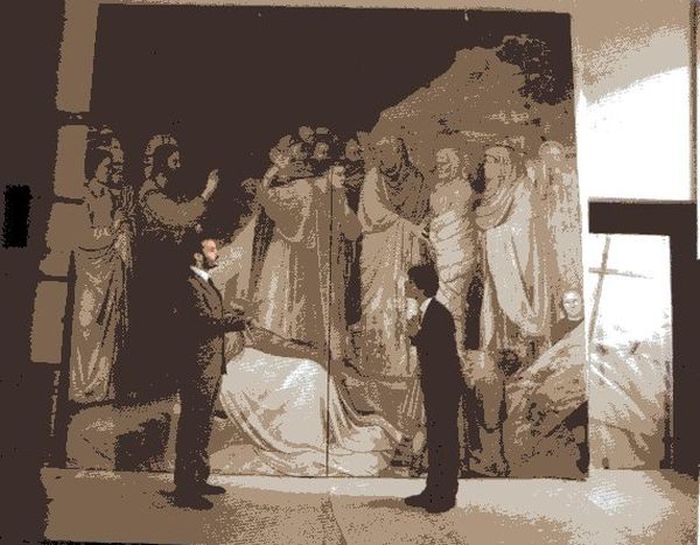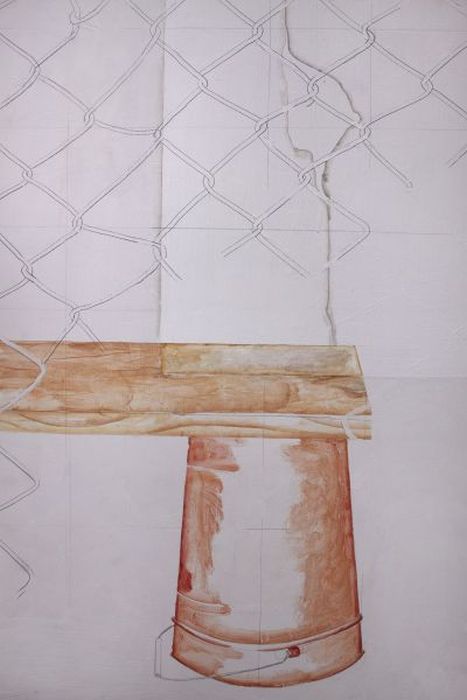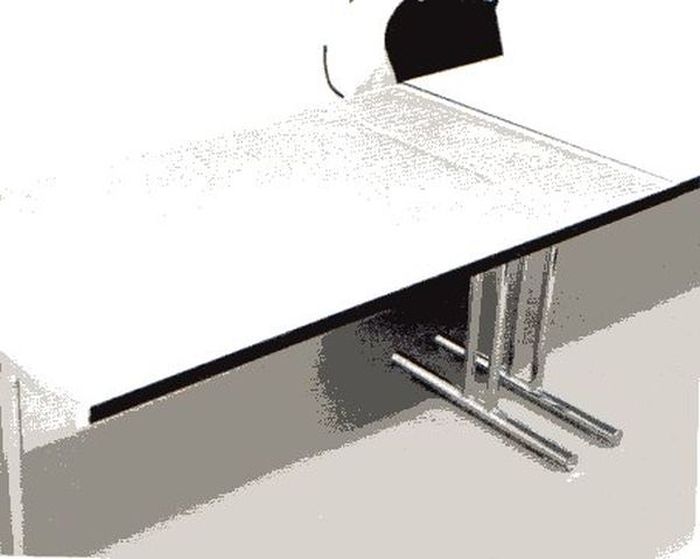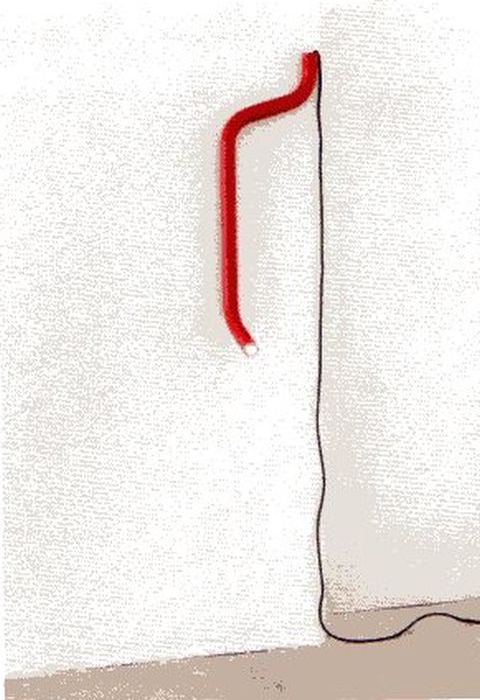di Romano Maria Levante
Francesco carissimo,
non avrei mai voluto ricevere la telefonata che mi ha sconvolto, sei scomparso, dopo aver raggiunto il culmine come Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, e aver poi proseguito come Garante del contribuente dell’Emilia-Romagna. Sono incredulo oltre che attonito, non è possibile, non è giusto, non può essere vero andarsene così il 3 marzo, l’ho saputo oggi nel giorno che mi si dice essere dei tuoi funerali, ci partecipo virtualmente, da Roma. E’ troppo crudele che la sorte ti abbia colpito in modo tanto spietato: perdere tua figlia Chiara vice-prefetto vicario di Modena, mentre combattevi contro un nemico invisibile a fianco della cara Wanda – colpita anch’essa pesantemente dal Covid, mentre tuo figlio avvocato lo ha avuto in forma più leggera – e dover cedere al morbo spietato quando la “guerra” contro il virus sembrava giunta al termine con le vaccinazioni, come per l’eroe di “All’Ovest niente di nuovo”!

Mai ti avevano piegato i criminali che avevi inchiodato alle loro responsabilità in nome della legge; neppure le temibili organizzazioni eversive le cui minacce avevano portato a blindare le finestre della tua bella abitazione in una zona residenziale della città, mi confidasti il tuo rammarico di averlo dovuto accettare. Nella mia immancabile telefonata di auguri pasquali dell’aprile scorso, nel pieno della “prima ondata” di pandemia, mi dicesti che con il grande giardino dove potevi passeggiare tranquillo e la via poco frequentata da te percorsa fino all’edicola per prendere il quotidiano non correvi rischi di contagio, cambiavi marciapiede se vedevi qualcuno avvicinarsi. Aggiungesti che avevi qualche timore per tua figlia le cui funzioni a Modena la esponevano agli inevitabili contatti; non potevi pensare che, dramma nel dramma, ingiustizia nell’ingiustizia, Chiara se ne sarebbe andata alcuni giorni prima di te, e non per il Covid. Di tutto questo non so darmi pace, mi chiedo angosciato perchè è stato possibile. Perché, perché, perché?
Come superare l’onda di pensieri che mi assale con il cuore in tumulto, che dire in un momento così sconvolgente, quando sembrano cadere le certezze e si è in preda allo sconforto? Ripiegarsi su sè stessi e immergersi nei ricordi, fare appello alla memoria quando la realtà diventa insostenibile pensando come sia disumano che chi, come te, si è sempre battuto per la giustizia abbia dovuto subire la massima ingiustizia che il destino potesse comminare. Il mio senso di umanità si ribella a una realtà che purtroppo si impone con la forza dei fatti, ma la mia ragione e il mio sentimento si rifiutano di accettare.
E allora per sconfiggere la morte chiamo a raccolta la vita, la tua vita, Francesco carissimo, che resta in tutto il suo splendore come se ci fossi ancora tu a testimoniarla con la tua presenza viva e vitale. A un certo punto della tua vita ci siamo incontrati, ed è bello ricordarlo per sentirti vicino.
Dalla Calabria dove sei nato il 25 giugno 1935, eri andato con la famiglia a 11 anni a Bologna, dove si sono svolti i tuoi studi ed è culminato il tuo prestigioso “cursus honorum”. E a Bologna ti ho incontrato al 2° liceo, venivo nella grande città dalla provincia, avevo frequentato a Teramo il ginnasio e 1° liceo, abbiamo condiviso come compagni di banco i due anni di liceo e la maturità al Liceo-ginnasio Marco Minghetti.
Agli inizi dell’aprile scorso, nell’isolamento ansioso del “lockdown”, il giorno del mio compleanno avevo sentito il bisogno di far rivivere in me le “radici” bolognesi entrando in contatto con l’Associazione dei Minghettiani, la presidente mi chiese di scrivere un ricordo, che fu pubblicato nelle “Testimonianze” del loro sito. Te ne parlai in una telefonata, mi aiutasti anche a ricordare il nome della nostra professoressa di scienze, che inserii nel mio scritto, spero tu abbia potuto leggere i miei ricordi, nei quali sei protagonista.
Citerò testualmente le parole di allora, non è l’emozione dolorosa di questo momento a suggerirmele, perciò rileggendole la ferita nel mio cuore si addolcisce nella memoria sempre viva. Ecco la parte della “testimonianza” in cui ci sei tu, soffusa di nostalgia cui si aggiunge ora l’amarezza portata dal dolore.
Ricordi comuni degli anni “minghettiani”
“I compagni sono ben presenti, questa volta sono il mio animo e il mio cuore ad essere investiti dalla marea di ricordi. Tra tutti Francesco Pintor, e non perché nella sua ‘escalation’ professionale sia assurto al massimo livello nella sua città, Procuratore generale della corte d’appello di Bologna, quanto perché fu lui, compagno di banco in quei due anni di liceo, a introdurre inizialmente il timido nuovo arrivato che si sentiva sperduto; mi recavo a trovarlo a casa con la sua famiglia, il padre colonnello dell’esercito, la colleganza divenne presto stretta amicizia, e così è rimasta.
“Ricordo quando andavo a vedere le gare studentesche allo Stadio, lui partecipava alle corse podistiche di resistenza, ma ricordo ben più nitidamente quando, forse mezzo secolo dopo, per un paio d’anni sono andato appositamente da Roma a Bologna per assistere alle inaugurazioni dell’Anno giudiziario che lo vedevano protagonista. Sempre con il suo piglio disincantato fuori da ogni conformismo, evidente all’inizio del solenne intervento quando, insofferente dell’ermellino, toglieva dal capo l’austero tocco scuotendo la massa dei capelli ribelli come una volta. Non ho dimenticato lo sguardo ‘assassino’ scambiato da lui, nella 3^ liceo, con una nostra compagna, Wanda Pasini, la più brava della classe in prima fila nel banco centrale, mentre io e Francesco eravamo al secondo banco nella fila laterale sinistra; di lì nacque un amore manifestatosi nel loro felice matrimonio, mi intrigava di aver colto il momento magico della prima scintilla.
“Un ricordo lieto, quando nel periodo in cui era membro del Consiglio Superiore della Magistratura ebbi il grande piacere di averlo a cena da me a Roma, si presentò con un bel mazzo di fiori per mia moglie; poi, nel giorno in cui l’ombra oscura dell’assassinio di Bachelet si proiettò sul CSM, gli telefonai a Bologna per rassicurarmi sulla sua incolumità, lo feci anche allo scoppio della bomba alla stazione, con lui e con i miei parenti in città, mia zia doveva prendere il treno in quei giorni.
“Francesco creò anche la saldatura dei ‘minghettiani’ con i ‘teramani’: nella vita professionale si incontrò con uno dei miei più cari compagni del 1° liceo a Teramo, Renato, che mi aveva raggiunto negli anni universitari a Bologna, era diventato anche vigile urbano motociclista, lo ricordo sulla sua moto scintillante nell’elegante divisa, mi sentivo piccolo piccolo sulla mia modesta Vespa. Dopo averlo saputo, sono andato più volte a Bologna per partecipare alle loro cene mensili con i colleghi, tanto era il legame affettivo; pochi anni fa Francesco mi ha dato la triste notizia della sua scomparsa nella telefonata di auguri pasquali, la successiva era per Renato, è stato un duro colpo. L’altro più caro compagno teramano a Bologna era Giorgio, molti anni dopo mi farà superare due problemi editoriali, l’ho già ricordato; stavamo spesso insieme, da dieci anni se n’è andato pure lui…
“Alla vista rasserenante di una serie di fotografie ‘d’epoca’ allontano questi pensieri: ecco la mia laurea con la corona d’alloro in testa e la festa delle matricole con il berretto universitario, è sempre con me Francesco, c’è l’impronta minghettiana, le ho messe vicino alla mia scrivania.
“Un’ulteriore immagine minghettiana che mi assale mi riporta alla recita del 3° anno, all’insegna del “dimetilchetone trinitotoluolo”, le astruse formule chimiche messe da noi alla berlina, io fui ‘immerso’ in pigiama rosa nel pentolone come novello esploratore arrostito dai selvaggi, i compagni saltellando mi lasciarono nel proscenio in tutta la mia timidezza ancora più indifesa”. Tra loro c’era, naturalmente, il compagno di banco Francesco.
“Ma irrompe una nuova immagine collegata ad un evento successivo di segno ben diverso. Riguarda il pomeriggio in cui, dopo la lezione di ginnastica, con un gruppo di compagni – sempre l’amico del cuore Francesco Pintor e ricordo anche Lello Limarzi, più grande ed ‘esperto’ di noi – andai in Via Valdonica, davanti a una di quelle “case” ancora aperte; io non salii e neppure altri di noi, mi è rimasta impressa quella via oscura dai piccoli portici maleodoranti, da antica suburra. Qualche anno fa ho rivisto in TV via Valdonica in una luce opposta, facciate e portici restaurati nel colore del cotto, la luminosità calda in contrasto con l’oscurità interiore calata su quella via con l’assassinio di Marco Biagi, una tragedia dolorosa che si sostituiva alla maliziosa memoria di allora.”
Il tuo “cursus honorum”, un’escalation appassionata
Sono ricordi lontani che tornano in questo momento, tristi e dolci insieme, perché da quegli anni prende avvio l’”escalation” che ti ha portato, Francesco carissimo, ai vertici della magistratura nella tua Bologna.
Inizia dalla tua laurea in Giurisprudenza nell’Università di Bologna nel 1958, discutendo una tesi di diritto processuale civile con il prof. Tito Carnicini, anch’io in Giurisprudenza discussi la tesi con il prof. Federico Caffè in economia politica, e da allora le nostre strade si divisero verso itinerari diversi; il tuo nel segno del Diritto come espressione della tua coscienza civile e del tuo culto della legalità.
Dopo l’ abilitazione alla professione forense nel 1960 il tuo ingresso in magistratura come uditore giudiziario impegnato nel tirocinio presso gli uffici giudiziari bolognesi, il Tribunale, la Procura, la Pretura. Poi hai operato nel territorio, Pretore a Rovigo, a Mantova ad Imola.
Dalla Pretura sei passato alla Procura, come Sostituto procuratore della Repubblica nella Procura di Bologna, quindi di nuovo funzioni giurisdizionali nel Tribunale di Bologna come Giudice nella 1^ sezione penale, dopo Giudice effettivo nella Corte d’assise, e applicato all’Ufficio di istruzione dei processi penali, non è mancata neppure un’esperienza alla 1^ sezione civile.
Nel 1982 l’importante tua nomina a Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna. Tra i tanti procedimenti in cui hai profuso il tuo impegno appassionato ne ricordo tre, di particolare rilievo, che ti hanno visto in vesti diverse: come giudice in Corte d’assise per i cosiddetti “fatti di Argelato”, l’omicidio di un brigadiere dei carabinieri nel corso di una rapina al locale zuccherificio; come pubblico ministero per la strage del treno “Italicus” e per l’omicidio del magistrato Mario Amato; il terzo che mi torna alla mente è per sequestro di persona a fini di estorsione con uccisione del sequestrato.
Alla fine degli anni ’80 la tua nomina per la nuova funzione introdotta nell’ordinamento di Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bologna, ricordo che mi parlasti di questo ruolo insolito. Finché, nel 1997, nominato Avvocato Generale nella Procura generale della Repubblica, ti sei avvicinato al culmine che hai raggiunto nel 2001 con l’incarico direttivo di Procuratore Generale della Repubblica per il distretto dell’Emilia Romagna. Lo sei stato per otto anni, fino alla pensione dell’aprile 2009, e ho ricordato prima quando venivo da Roma per assistere all’inaugurazione dell’anno giudiziario, felice e orgoglioso che a celebrarla fosse il mio antico compagno di banco. Mio figlio Alberto mi ricorda quando venimmo a trovarti a casa a Bologna all’inizio del nostro viaggio in Europa dopo la sua maturità.
Ma non è tutto qui il tuo “cursus honorum” giudiziario, sei stato anche componente effettivo del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Bologna per due bienni dal 1971 al 1975, e soprattutto membro del Consiglio Superiore della Magistratura per quasi 5 anni, del 18 dicembre 1976 al 9 luglio 1981; erano gli “anni di piombo”, fu assassinato dalle BR il vice presidente del CSM Bachelet, cui subentrò Conso, ne erano presidenti i capi dello Stato Leone e poi Pertini. In quel periodo sei venuto a casa mia a Roma, l’ho ricordato nella testimonianza ai nostri compagni Minghettiani.
Hai fatto parte, oltre che della 3^ Commissione referente del CSM, della Commissione ministeriale per la riforma organica dell’ordinamento giudiziario istituita nel 1982 e della Commissione ministeriale per le attività di formazione e aggiornamento professionale in vista dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale istituita nel 1987.
Con l’andata in pensione nel 2009 non ti sei fermato, tutt’altro: ed ecco senza soluzione di continuità la nomina con decreto della Commissione Regionale Tributaria a Presidente dell’Ufficio del Garante del Contribuente per l’Emilia Romagna, inizialmente per il quadriennio 2009 –2013, poi hai continuato. Me ne parlavi con la soddisfazione di poter affrontare di nuovo direttamente le questioni giuridiche che ti appassionavano dopo anni in cui l’alto livello raggiunto comportava soprattutto funzioni di coordinamento; quando con i tagli governativi non potevi più contare sui due magistrati facenti parte del tuo ufficio il lavoro divenne ancora più gravoso e ti preoccupava.
Sembrerebbe completo l’arco della tua attività instancabile all’insegna del diritto e per la legalità, ma c’è dell’altro ancora, e riguarda la condivisione di quanto acquisito con la tua passione, la tua energia e determinazione. Lo hai fatto su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura con le tue dotte relazioni negli incontri di studio riservati ai magistrati; lo hai fatto anche come docente nella sede di Bologna della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nei corsi di formazione per funzionari del ministero della Giustizia, sull’ “Ordinamento giudiziario”, e per funzionari alla Corte dei Conti sui “Reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”. E hai svolto numerosi seminari di studio nel corso di “Ordinamento e deontologia giudiziaria” della Scuola di specializzazione per le professioni forensi “E. Redenti” dell’Università degli studi di Bologna in vari anni accademici. La partecipazione da relatore a numerosi convegni soprattutto in materia giuridica e medico-legale fino alle serate del “Martedì di San Domenico” organizzate dal Centro domenicano a Bologna sono altre tessere del tuo straordinario mosaico professionale.
Ecco come ti sei espresso il 30 aprile 2009, nell’ultima giornata in magistratura prima della pensione, ed è stata l’unica intervista che hai concesso – al giornale bolognese “Il Resto del Carlino” – nei 47 anni di intensa attività, in un riserbo esemplare, ulteriore specchio della tua serietà. “Il mio sogno, fin da piccolo, era di fare il magistrato. Mio padre era militare, mio nonno avvocato, in famiglia c’erano zii magistrati. Sono riuscito a coronare questo sogno e il bilancio per me è positivo. Di ciò che ho fatto non cambierei nulla”.
“Quella del magistrato – dicevi all’intervistatore – è una funzione altissima, che richiede però grandi sacrifici. Sapesse quanto travaglio. Dover operare una scelta in tanti processi, senza essere sicuro della verità. Ma questo è il dovere del giudice. L’importante è poter andare a riposare, la sera, senza che la coscienza rimorda. Poter chiudere gli occhi sapendo di aver fatto il proprio dovere, in assoluta buona fede”. E lo hai fatto quando li hai chiusi l’ultima volta per sempre sapendo che hai continuato a fare il tuo dovere come Garante dei diritti del contribuente oltre che da cittadino e padre di famiglia, della tua bella famiglia.
Hai ricordato i momenti più difficili, con l’angoscia degli “anni di piombo”: quando ti precipitasti in Via Valdonica dove era stato assassinato Marco Biagi, mentre partecipavi a un incontro ai “Martedì di San Domenico”; e quando fosti tra i primi ad accorrere dopo l’omicidio del vicepresidente Bachelet negli anni del CSM. E i momenti fonte per te di soddisfazioni, come la soluzione di casi intricati di omicidi efferati.
Di quell’intervista voglio sottolineare infine la tua risposta alla domanda se consiglieresti a un giovane di diventare magistrato: “Gli direi di farlo, purché ci si approcci con passione. Questo non è come qualunque altro lavoro. Va fatto con sentimento, passione, senso di responsabilità e grandissima umiltà. Ai giovani dico di non scoraggiarsi, di non avere paura, e di farsi guidare sempre da scienza e coscienza”. Aggiungesti anche: “Servono forze nuove, giovani, che sono la linfa necessaria per un ricambio generazionale”.
Le tue doti professionali e umane, nel ricordo della nuova generazione di magistrati
Nel rievocare tutto questo, sento un profondo rammarico: non averti seguito nelle fasi esaltanti del tuo prestigioso itinerario professionale operando in un campo ben diverso – l’economia e la pianificazione aziendale a livello dirigenziale sul piano professionale, il giornalismo economico e poi culturale sul piano personale – e non poterne quindi cogliere di volta in volta gli elementi qualificanti nei quali rifulge la tua personalità. Mi dicesti che leggevi i trattati di “Logica” per affinare gli strumenti di analisi e valutazione, ma parlavi poco della tua attività forse per non mettermi in imbarazzo essendo la mia tanto lontana dalla tua. Perciò mi affido alle parole di tre magistrati della nuova generazione – le “forze nuove, giovani” che hai definito “la linfa necessaria per un ricambio generazionale” – i quali invece hanno avuto la fortuna di seguirti e mostrano l’alta considerazione e la devozione che sento di provare anch’io, pur su altre basi.
Il magistrato Carlo Coco ricorda le tue “elevatissime doti professionali e umane” che “hanno onorato l’istituzione cui apparteniamo e sono state di esempio per una generazione di colleghi dell’Emilia-Romagna”, e sintetizza in una parola il suo “commosso ricordo: autorevolezza. Era questo il messaggio che ogni giovane magistrato ha ricevuto“ da te, “ e dall’esempio di tale autorevolezza discendeva per noi una sicura motivazione a svolgere le nostre funzioni con serietà, impegno, sacrificio, ferma determinazione e tuttavia, sempre, con umiltà”; sono le doti che anche negli anni liceali rifulgevano, unite a un atteggiamento disincantato sempre volto a sdrammatizzare, ricordo che ti esibivi nei passi di danza di Gene Kelly nel tuo personale “Cantando sotto la pioggia”. Coco sottolinea che la tua “dedizione allo Stato e ai cittadini” si è manifestata , oltre che nell’attività giurisdizionale e nella guida degli uffici, “anche con l’impegno di altissimo profilo profuso nella rappresentanza istituzionale della Magistratura” nel CSM e nell’ANM; nel quale hai operato “in modo cristallino, con assoluta imparzialità, profondo senso delle istituzioni e intima convinzione dell’importanza della rappresentanza unitaria della Magistratura”. Conclude in modo accorato: “Riposa in pace, Francesco (solo ora posso darti del tu)”.
Marco D’Orazi, magistrato “figlio d’arte”, si lascia andare ai ricordi d’infanzia quando nelle vacanze accompagnava il padre tuo collega nelle camminate con te in montagna dove “brontolando” imparava “la disciplina del ‘never explain never complain’ (‘vi riposerete quando arriveremo al rifugio’), il senso di responsabilità… la bellezza di raggiungere uno scopo comune”. E non solo, via via imparava “una lezione preziosa” che lo ha accompagnato nella “vita, professionale e non”, cioè “il senso del servizio alla Repubblica, l’equilibro personale che è alla base di ogni buon magistrato, il prendere sul serio il proprio lavoro senza personalismi”. D’Orazio ha rievocato, carissimo Francesco, che nella cena del tuo pensionamento dicesti che “il diritto e il lavoro erano una parte essenziale dell’’essere Pintor’”e che avresti continuato così, “così è stato”. Ricorda anche che la tua amata Chiara era tra i figli piccoli che come lui accompagnavano i padri magistrati nelle camminate educative prima evocate, e forse alla sua prematura scomparsa non ha retto una “fibra fortissima come la tua”, la tragedia nella tragedia. Dopo l’accorato “tu” di Coco l’altrettanto accorato “lei” di D’Orazio: “Ai grandi si dà del lei, ci dicevano. Dunque la saluto, caro Procuratore, le sia lieve la terra!”.
L’ultimo ricordo di magistrati della nuova generazione che voglio citare è di Marco Forte, lo ringrazio per aver dato queste testimonianze a una persona sua amica a me vicina che me le ha premurosamente trasmesse: anche lui “figlio d’arte” partecipava da bambino alle camminate… educative ricordate da D’Orazi, e ricorda “con nostalgia quando da inesperto uditore giudiziario mi rivolgevo al procuratore della Circondariale con l’imbarazzo del figlio del collega ed amico di una vita”. Ma aggiunge un episodio che va al di là di ogni altro giudizio per descrivere la tua più profonda sensibilità: “Tra i tanti ricordi ci sarà sempre quello di una fredda mattina all’Ospedale Maggiore dove per primo ti precipitasti per dare l’estremo saluto a mio padre, scusandoti con noi figli per averci quasi anticipati, mostrando ancora una volta quel tratto di umanità fuori dal comune che ti ha sempre contraddistinto”. Mi sono permesso di volgere al tu invece della terza persona il ricordo di te che ha Marco Forte, ancora con “l’imbarazzo del figlio del collega ed amico di una vita”, è così intenso il suo messaggio che ho voluto accomunarlo al mio. Inizia così: “Un profondo dolore, anche pensando alla tragedia della recentissima perdita di Chiara, toglie tutte le parole per ricordare un grande Uomo e Magistrato”; e dopo la rievocazione del triste momento in cui deste l’estremo saluto al padre, termina con un commosso: “Grazie di tutto Sig. Procuratore!”
“Amor omnia vincit”!
Mi unisco anch’io al ringraziamento del magistrato Marco Forte, dopo essermi immedesimato in queste rievocazioni del tanto e del troppo che si sottrae ai miei ricordi diretti. In campo giudiziario ho condiviso con te, sul nostro comune banco liceale, l’emozione alla condanna di Giovannino Guareschi per il “Ta pum del cecchino”, e al suo orgoglioso “No, niente appello”, fino alla reclusione con la toccante vignetta che lo mostra sulla via del carcere mentre saluta con le parole: “Ci appelliam solo alla Storia/ nè si offusca il nostro onore/ se la via della vittoria/ mi conduce a San Vittore”. Ricordi? era l’aprile 1954, l’anno della maturità. Parecchi anni fa ti ho fatto avere un voluminoso fascicolo con tutti gli articoli e le vignette sul tema nel “Candido” di cui ho conservato le annate, e in seguito gli articoli che ho pubblicato sulla vicenda che ci prese intimamente, la seguimmo insieme con passione. Fin da allora il tuo senso della giustizia e della legalità, insieme alla tua profonda umanità, era incrollabile; poi lo hai messo in pratica con ferma determinazione, e i riconoscimenti della nuova generazione di magistrati che ti vede come esempio luminoso devono darti la soddisfazione che quanto hai seminato ha dato e continua a dare i suoi frutti.
In questo senso, come nel finale di “Furore” di Steimbeck, ci sarà sempre la tua presenza virtuale allorchè saranno in gioco i valori in cui hai creduto e per i quali hai operato nei luoghi in cui hai svolto con fermezza e spirito di umanità in una dedizione appassionata il tuo alto servizio alla giustizia e alla legalità. Da studenti, per il tuo modo di fare disinvolto e coinvolgente, entusiasta e deciso, ti identificavo con Frank Sinatra di “Da qui all’eternità”, il film cult che vedemmo allora: ebbene ora l’hai raggiunta!
E’ arrivato il momento di salutarti, Francesco carissimo, mi accorgo che, come al tuo più giovane collega Forte, la tragedia che ti ha colpito e ci ha sconvolti toglie a me tutte le parole. Non resta che fare appello alla fede, per trovare consolazione in quello che nell’al di là potrà compensarti di quanto hai profuso nella tua vita esemplare, e le poche citazioni che ne ho potuto fare sono di per sé già molto espressive.
Per la tua carissima Wanda – la quale deve essere aiutata a trovare la forza per reagire a una tale doppia insostenibile tragedia dopo aver lottato anche lei in terapia intensiva – temo che noi potremo fare ben poco pur con la nostra affettuosa vicinanza. Sarai tu che dall’alto saprai aiutarla consolandola con la tua presenza amorevole, invisibile ma non meno viva di quella che vi ha uniti in un sentimento iniziato dai banchi del liceo e protrattosi con tanta appassionata intensità nella vostra lunga vita d’amore. “Amor omnia vincit”!

foto Michele Nucci